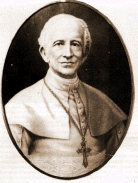PARTE QUARTA (CCC)
LA PREGHIERA CRISTIANA
SEZIONE PRIMA
LA PREGHIERA NELLA VITA CRISTIANA
CAPITOLO PRIMO
LA RIVELAZIONE DELLA PREGHIERA
ARTICOLO 2
NELLA PIENEZZA DEL TEMPO
2598 L'evento della preghiera ci viene pienamente rivelato nel Verbo che si è fatto carne e dimora in mezzo a noi. Cercare di comprendere la sua preghiera, attraverso ciò che i suoi testimoni ci dicono di essa nel Vangelo, è avvicinarci al santo Signore Gesù come al roveto ardente: dapprima contemplarlo mentre prega, poi ascoltare come ci insegna a pregare, infine conoscere come egli esaudisce la nostra preghiera.
Gesù prega
2599 Il Figlio di Dio diventato Figlio della Vergine ha anche imparato a pregare secondo il suo cuore d'uomo. Egli apprende le formule di preghiera da sua Madre, che serbava e meditava nel suo cuore tutte le « grandi cose » fatte dall'Onnipotente.51 Egli prega nelle parole e nei ritmi di preghiera del suo popolo, nella sinagoga di Nazaret e al Tempio. Ma la sua preghiera sgorga da una sorgente ben più segreta, come lascia presagire già all'età di dodici anni: « Io devo occuparmi delle cose del Padre mio » (Lc 2,49). Qui comincia a rivelarsi la novità della preghiera nella pienezza dei tempi: la preghiera filiale, che il Padre aspettava dai suoi figli, viene finalmente vissuta dallo stesso Figlio unigenito nella sua umanità, con gli uomini e per gli uomini.
2600 Il Vangelo secondo san Luca sottolinea l'azione dello Spirito Santo e il senso della preghiera nel ministero di Cristo. Gesù prega prima dei momenti decisivi della sua missione: prima che il Padre gli renda testimonianza, al momento del suo battesimo52 e della trasfigurazione,53 e prima di realizzare, mediante la sua passione, il disegno di amore del Padre.54 Egli prega anche prima dei momenti decisivi che danno inizio alla missione dei suoi Apostoli: prima di scegliere e chiamare i Dodici,55 prima che Pietro lo confessi come « il Cristo di Dio »56 e affinché la fede del capo degli Apostoli non venga meno nella tentazione.57 La preghiera di Gesù prima delle azioni salvifiche che il Padre gli chiede di compiere, è un'adesione umile e fiduciosa della sua volontà umana alla volontà piena d'amore del Padre.
2601 « Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e, quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: "Signore, insegnaci a pregare" » (Lc 11,1). Non è forse anzitutto contemplando il suo Maestro orante che nel discepolo di Cristo nasce il desiderio di pregare? Può allora impararlo dal Maestro della preghiera. È contemplando ed ascoltando il Figlio che i figli apprendono a pregare il Padre.
2602 Gesù si ritira spesso in disparte, nella solitudine, sulla montagna, generalmente di notte, per pregare.58 Egli porta gli uomini nella sua preghiera, poiché egli ha pienamente assunto l'umanità nella sua incarnazione, e li offre al Padre offrendo se stesso. Egli, il Verbo che « si è fatto carne », nella sua preghiera umana partecipa a tutto ciò che vivono i « suoi fratelli »;59 compatisce le loro infermità per liberarli da esse.60 Proprio per questo il Padre l'ha mandato. Le sue parole e le sue azioni appaiono allora come la manifestazione visibile della sua preghiera « nel segreto ».
2603 Gli evangelisti hanno riportato in modo esplicito due preghiere pronunciate da Gesù durante il suo ministero. Ognuna comincia con il rendimento di grazie. Nella prima,61 Gesù confessa il Padre, lo riconosce e lo benedice perché ha nascosto i misteri del Regno a coloro che si credono dotti e li ha rivelati ai « piccoli » (i poveri delle beatitudini). Il suo trasalire: « Sì, Padre! » esprime la profondità del suo cuore, la sua adesione al « beneplacito » del Padre, come eco al « Fiat » di sua Madre al momento del suo concepimento e come preludio a quello che egli dirà al Padre durante la sua agonia. Tutta la preghiera di Gesù è in questa amorosa adesione del suo cuore di uomo al « mistero della volontà » del Padre.62
2604 La seconda preghiera è riferita da san Giovanni63 prima della risurrezione di Lazzaro. L'azione di grazie precede l'evento: « Padre, ti ringrazio che mi hai ascoltato », il che implica che il Padre ascolta sempre la sua supplica; e Gesù subito aggiunge: « Io sapevo che sempre mi dai ascolto », il che implica che Gesù, dal canto suo, domanda in modo costante. Così, introdotta dal rendimento di grazie, la preghiera di Gesù ci rivela come chiedere: prima che il dono venga concesso, Gesù aderisce a colui che dona e che nei suoi doni dona se stesso. Il Donatore è più prezioso del dono accordato; è il « Tesoro », ed il cuore del Figlio suo è in lui; il dono viene concesso « in aggiunta ».64
La « preghiera sacerdotale » di Gesù65 occupa un posto unico nell'Economia della salvezza. Su di essa si mediterà nella parte conclusiva della sezione prima. In realtà essa rivela la preghiera sempre attuale del nostro Sommo Sacerdote, e, al tempo stesso, è intessuta di ciò che Gesù ci insegna nella nostra preghiera al Padre, che sarà commentata nella sezione seconda.
2605 Quando giunge l'Ora in cui porta a compimento il disegno di amore del Padre, Gesù lascia intravvedere l'insondabile profondità della sua preghiera filiale, non soltanto prima di consegnarsi volontariamente (« Padre,... non... la mia, ma la tua volontà »: Lc 22,42), ma anche nelle ultime sue parole sulla croce, là dove pregare e donarsi si identificano: « Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno » (Lc 23,34); « In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso » (Lc 23,43); « Donna, ecco il tuo figlio. [...] Ecco la tua Madre » (Gv 19,26-27); « Ho sete! » (Gv 19,28); « Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? » (Mc 15,34);66 « Tutto è compiuto! » (Gv 19,30); « Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito » (Lc 23,46), fino a quel « forte grido » con il quale muore, rendendo lo spirito.67
2606 Tutte le angosce dell'umanità di ogni tempo, schiava del peccato e della morte, tutte le implorazioni e le intercessioni della storia della salvezza confluiscono in questo grido del Verbo incarnato. Ed ecco che il Padre le accoglie e, al di là di ogni speranza, le esaudisce risuscitando il Figlio suo. Così si compie e si consuma l'evento della preghiera nell'Economia della creazione e della salvezza. Il Salterio ce ne offre la chiave in Cristo. È nell'oggi della risurrezione che il Padre dice: « Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato. Chiedi a me, ti darò in possesso le genti e in dominio i confini della terra! » (Sal 2,7-8).68
La lettera agli Ebrei esprime in termini drammatici come la preghiera di Gesù operi la vittoria della salvezza: « Nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà; pur essendo Figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono » (Eb 5,7-9).
Gesù insegna a pregare
2607 Quando Gesù prega, già ci insegna a pregare. Il cammino teologale della nostra preghiera è la sua preghiera al Padre. Ma il Vangelo ci offre un esplicito insegnamento di Gesù sulla preghiera. Come un pedagogo, egli ci prende là dove siamo e, progressivamente, ci conduce al Padre. Rivolgendosi alle folle che lo seguono, Gesù prende le mosse da ciò che queste già conoscono della preghiera secondo l'Antica Alleanza e le apre alla novità del Regno che viene. Poi rivela loro tale novità con parabole. Infine, ai suoi discepoli, che dovranno essere pedagoghi della preghiera nella sua Chiesa, parlerà apertamente del Padre e dello Spirito Santo.
2608 Fin dal discorso della montagna, Gesù insiste sulla conversione del cuore: la riconciliazione con il fratello prima di presentare un'offerta sull'altare,69 l'amore per i nemici e la preghiera per i persecutori,70 la preghiera al Padre « nel segreto » (Mt 6,6), senza sprecare molte parole,71 il perdono dal profondo del cuore nella preghiera,72 la purezza del cuore e la ricerca del Regno.73 Tale conversione è tutta orientata al Padre: è filiale.
2609 Il cuore, deciso così a convertirsi, apprende a pregare nella fede. La fede è un'adesione filiale a Dio, al di là di ciò che sentiamo e comprendiamo. È diventata possibile perché il Figlio diletto ci apre l'accesso al Padre. Egli può chiederci di « cercare » e di « bussare », perché egli stesso è la porta e la via.74
2610 Come Gesù prega il Padre e rende grazie prima di ricevere i suoi doni, così egli ci insegna questa audacia filiale: « Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto » (Mc 11,24). Tale è la forza della preghiera: « Tutto è possibile per chi crede » (Mc 9,23), con una fede che non dubita.75 Quanto Gesù è rattristato dalla « incredulità » (Mc 6,6) dei suoi compaesani e dalla poca fede dei suoi discepoli,76 tanto si mostra pieno di ammirazione davanti alla fede davvero grande del centurione romano77 e della Cananea.78
2611 La preghiera di fede non consiste soltanto nel dire: « Signore, Signore », ma nel disporre il cuore a fare la volontà del Padre.79 Gesù esorta i suoi discepoli a portare nella preghiera questa passione di collaborare al disegno divino.80
2612 In Gesù « il regno di Dio è vicino » (Mc 1,15); egli chiama alla conversione e alla fede, ma anche alla vigilanza. Nella preghiera, il discepolo veglia attento a colui che è e che viene, nella memoria della sua prima venuta nell'umiltà della carne e nella speranza del suo secondo avvento nella gloria.81 La preghiera dei discepoli, in comunione con il loro Maestro, è un combattimento, ed è vegliando nella preghiera che non si entra in tentazione.82
2613 Tre parabole sulla preghiera di particolare importanza ci sono tramandate da san Luca:
La prima, « l'amico importuno »,83 esorta ad una preghiera fatta con insistenza: « Bussate e vi sarà aperto ». A colui che prega così, il Padre del cielo « darà tutto ciò di cui ha bisogno », e principalmente lo Spirito Santo che contiene tutti i doni.
La seconda, « la vedova importuna »,84 è centrata su una delle qualità della preghiera: si deve pregare sempre, senza stancarsi, con la pazienza della fede. « Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? ».
La terza parabola, « il fariseo e il pubblicano »,85 riguarda l'umiltà del cuore che prega: « O Dio, abbi pietà di me, peccatore ». La Chiesa non cessa di fare sua questa preghiera: « Kyrie eleison! ».
2614 Quando Gesù confida apertamente ai suoi discepoli il mistero della preghiera al Padre, svela ad essi quale dovrà essere la loro preghiera, e la nostra, allorquando egli, nella sua umanità glorificata, sarà tornato presso il Padre. La novità, attualmente, è di « chiedere nel suo nome ».86 La fede in lui introduce i discepoli nella conoscenza del Padre, perché Gesù è « la via, la verità e la vita » (Gv 14,6). La fede porta il suo frutto nell'amore: osservare la sua parola, i suoi comandamenti, dimorare con lui nel Padre, che in lui ci ama fino a prendere dimora in noi. In questa nuova Alleanza, la certezza di essere esauditi nelle nostre suppliche è fondata sulla preghiera di Gesù.87
2615 Ancor più, quando la nostra preghiera è unita a quella di Gesù, il Padre ci dà un « altro Consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità » (Gv 14,16-17). Questa novità della preghiera e delle sue condizioni appare attraverso il discorso di addio.88 Nello Spirito Santo, la preghiera cristiana è comunione di amore con il Padre, non solamente per mezzo di Cristo, ma anche in lui: « Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena » (Gv 16,24).
Gesù esaudisce la preghiera
2616 La preghiera a Gesù è già esaudita da lui durante il suo ministero, mediante segni che anticipano la potenza della sua morte e della sua risurrezione: Gesù esaudisce la preghiera di fede, espressa a parole (dal lebbroso;89 da Giairo;90 dalla Cananea;91 dal buon ladrone92) oppure in silenzio (da coloro che portano il paralitico;93 dall'emoroissa che tocca il suo mantello;94 dalle lacrime e dall'olio profumato della peccatrice95). La supplica accorata dei ciechi: « Figlio di Davide, abbi pietà di noi » (Mt 9,27) o: « Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me » (Mc 10,47) è stata ripresa nella tradizione della Preghiera a Gesù: « Gesù, Cristo, Figlio di Dio, Signore, abbi pietà di me peccatore! ». Si tratti di guarire le malattie o di rimettere i peccati, alla preghiera che implora con fede Gesù risponde sempre: « Va' in pace, la tua fede ti ha salvato! ».
Sant'Agostino riassume in modo mirabile le tre dimensioni della preghiera di Gesù: « Prega per noi come nostro Sacerdote; prega in noi come nostro Capo; è pregato da noi come nostro Dio. Riconosciamo, dunque, in lui la nostra voce, e in noi la sua voce ».96
La preghiera della Vergine Maria
2617 La preghiera di Maria ci è rivelata all'aurora della pienezza dei tempi. Prima dell'incarnazione del Figlio di Dio e prima dell'effusione dello Spirito Santo, la sua preghiera coopera in una maniera unica al disegno benevolo del Padre: al momento dell'annunciazione per il concepimento di Cristo,97 e in attesa della pentecoste per la formazione della Chiesa, corpo di Cristo.98 Nella fede della sua umile serva il dono di Dio trova l'accoglienza che fin dall'inizio dei tempi aspettava. Colei che l'Onnipotente ha fatto « piena di grazia », risponde con l'offerta di tutto il proprio essere: « Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto ». « Fiat », è la preghiera cristiana: essere interamente per lui, dal momento che egli è interamente per noi.
2618 Il Vangelo ci rivela come Maria preghi e interceda nella fede: a Cana99 la Madre di Gesù prega il Figlio suo per le necessità di un banchetto di nozze, segno di un altro Banchetto, quello delle nozze dell'Agnello che, alla richiesta della Chiesa, sua Sposa, offre il proprio Corpo e il proprio Sangue. Ed è nell'ora della Nuova Alleanza, ai piedi della croce, 100 che Maria viene esaudita come la Donna, la nuova Eva, la vera « Madre dei viventi ».
2619 È per questo che il cantico di Maria, 101 il « Magnificat » latino, il 9,("8L
< bizantino, rappresenta ad un tempo il cantico della Madre di Dio e quello della Chiesa, cantico della Figlia di Sion e del nuovo popolo di Dio, cantico di ringraziamento per la pienezza di grazie elargite nell'Economia della salvezza, cantico dei « poveri », la cui speranza si realizza mediante il compimento delle promesse fatte ai nostri padri, « ad Abramo e alla sua discendenza per sempre ».
In sintesi
2620 Nel Nuovo Testamento il modello perfetto della preghiera si trova nella preghiera filiale di Gesù. Fatta spesso nella solitudine, nel silenzio, la preghiera di Gesù comporta un'adesione piena d'amore alla volontà del Padre fino alla croce e un'assoluta fiducia di essere esaudito.
2621 Nel suo insegnamento, Gesù educa i suoi discepoli a pregare con un cuore purificato, con una fede viva e perseverante, con un'audacia filiale. Li esorta alla vigilanza e li invita a rivolgere le loro domande a Dio nel suo nome. Gesù Cristo stesso esaudisce le preghiere che gli vengono rivolte.
2622 La preghiera della Vergine Maria, nel suo « Fiat » e nel suo Magnificat, è caratterizzata dalla generosa offerta di tutto il suo essere nella fede.
(51) Cf Lc 1,49; 2,19; 2,51.
(52) Cf Lc 3,21.
(53) Cf Lc 9,28.
(54) Cf Lc 22,41-44.
(55) Cf Lc 6,12.
(56) Cf Lc 9,18-20.
(57) Cf Lc 22,32.
(58) Cf Mc 1,35; 6,46; Lc 5,16.
(59) Cf Eb 2,12.
(60) Cf Eb 2,15; 4,15.
(61) Cf Mt 11,25-27 e Lc 10,21-22.
(62) Cf Ef 1,9.
(63) Cf Gv 11,41-42.
(64) Cf Mt 6,21.33.
(65) Cf Gv 17.
(66) Cf Sal 22,2.
(67) Cf Mc 15,37; Gv 19,30.
(68) Cf At 13,33.
(69) Cf Mt 5,23-24.
(70) Cf Mt 5,44-45.
(71) Cf Mt 6,7.
(72) Cf Mt 6,14-15.
(73) Cf Mt 6,21.25.33.
(74) Cf Mt 7,7-11.13-14.
(75) Cf Mt 21,21.
(76) Cf Mt 8,26.
(77) Cf Mt 8,10.
(78) Cf Mt 15,28.
(79) Cf Mt 7,21.
(80) Cf Mt 9,38; Lc 10,2; Gv 4,34.
(81) Cf Mc 13; Lc 21,34-36.
(82) Cf Lc 22,40.46.
(83) Cf Lc 11,5-13.
(84) Cf Lc 18,1-8.
(85) Cf Lc 18,9-14.
(86) Cf Gv 14,13.
(87) Cf Gv 14,13-14.
(88) Cf Gv 14,23-26; 15,7.16; 16,13-15.23-27.
(89) Cf Mc 1,40-41.
(90) Cf Mc 5,36.
(91) Cf Mc 7,29.
(92) Cf Lc 23,39-43.
(93) Cf Mc 2,5.
(94) Cf Mc 5,28.
(95) Cf Lc 7,37-38.
(96) Sant'Agostino, Enarratio in Psalmum 85, 1: CCL 39, 1176 (PL 36, 1081); cf Principi e norme per la Liturgia delle Ore, 7: Liturgia delle Ore, v. 1 (Libreria Editrice Vaticana 1981) p. 30.
(97) Cf Lc 1,38.
(98) Cf At 1,14.
(99) Cf Gv 2,1-12.
(100) Cf Gv 19,25-27.
(101) Cf Lc 1,46-55.